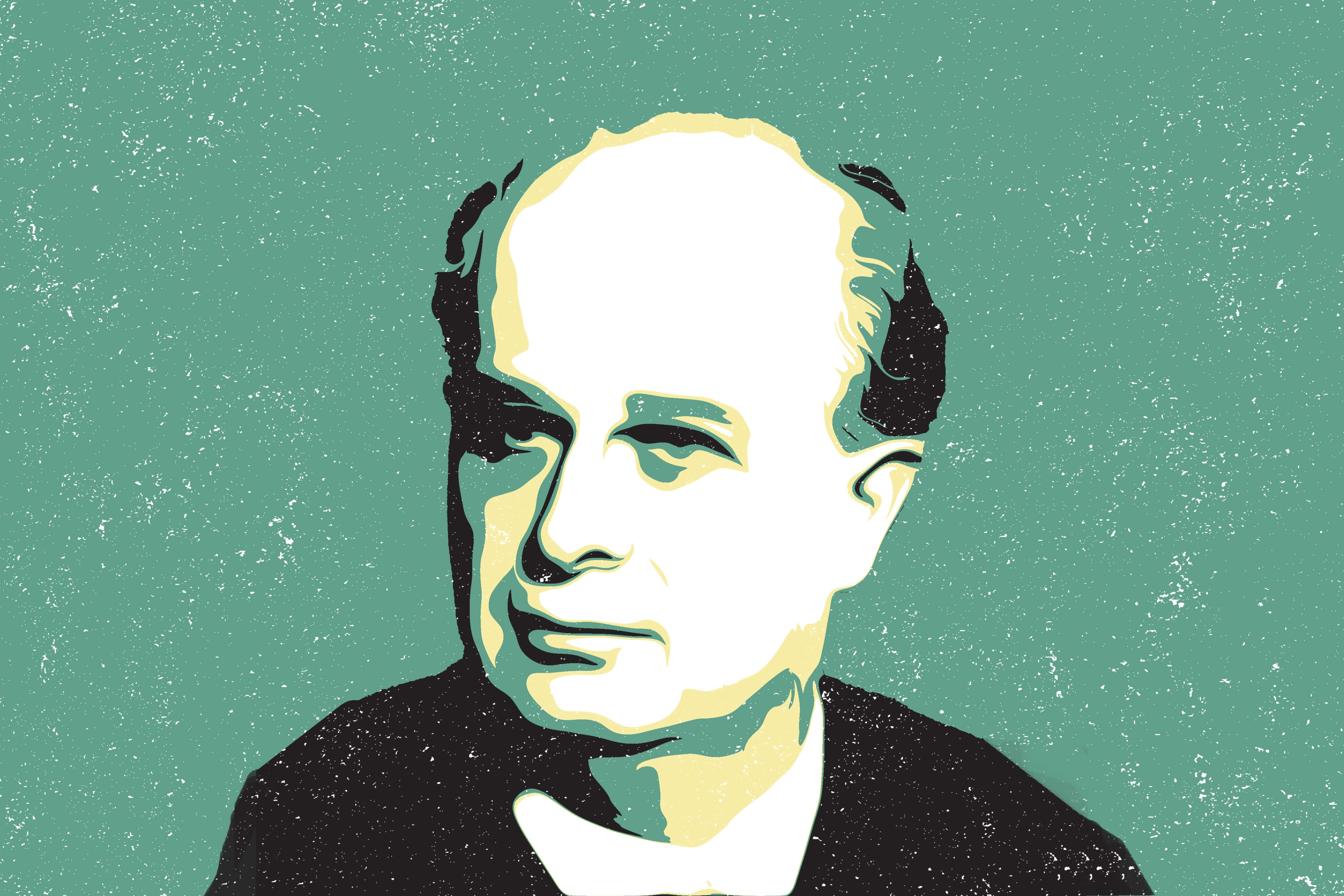Delle cinque carriere toccatemi in una vita che non si può francamente considerare troppo breve – traduttore per Einaudi, consulente industriale, diplomatico internazionale all’OECE, ora OCSE, deputato indipendente nella Terza legislatura, professore universitario – credo che quella vissuta con Adriano Olivetti, dal primo casuale incontro nel 1948 alla sua morte nel 1960, sia stata la più straordinaria.
Non per merito mio, ma per le qualità dell’uomo. Alla sua morte, molti scrittori e giornalisti, in perfetta buona fede, ne parlarono e scrissero come di un «buon padrone» e di un «capitalista illuminato». Giudizi corrivi e superficiali. Olivetti ne sarebbe stato inorridito. In realtà, era un uomo fuori dalle categorie consuete; non era facilmente classificabile; rompeva gli schemi; trascendeva la cruda datità delle circostanze.
Ecco un capitalista che non crede e intende, anzi, trasformare il capitalismo; un ingegnere laureato al Politecnico di Torino, che non è mai vittima di quello che Friedrich Von Hayek definiva l’esprit polytechnicien; un imprenditore, si direbbe suo malgrado, perdutamente innamorato delle bellezze naturali del territorio, che tuttavia da una piccola fabbrica in mattoni rossi, ereditata dal padre Camillo per la produzione di «cembali scrivani», vale a dire macchine per scrivere, in pochi anni la trasforma in una delle più importanti multinazionali italiane, con prodotti famosi per l’efficienza tecnica e l’estetica formale. La Lettera 22 viene esposta per settimane al Museum of Modern Art di New York, come una scultura di Moore o un quadro di Van Gogh.
Quest’uomo, che non ha orecchio per la musica ma sente cantare le pietre, sa cos’è il profitto e sa farlo. Il profitto è ovviamente il risultato della differenza fra costo di produzione e prezzo di vendita. Ma Olivetti è consapevole che il profitto non va perseguito a tutti i costi né va massimizzato nel più breve tempo possibile, senza tener conto delle condizioni che garantiscano l’equilibrio eco-sistemico della comunità.
Anche il mercato per Adriano Olivetti è importante e legittimo come foro di negoziazione e di contrattazione. Ma non è un totem salvifico. Quando un’economia di mercato è troppo forte e invadente rischia di tracimare e tende a trasformare la società in società di mercato, cioè in non-società, in cui gli stessi rapporti interpersonali più intimi si fanno rapporti utilitari. Si rischia allora il ritorno all’hobbesiano «bellum omnium contra omnes» e all’«homo homini lupus»:
Per questa fondamentale ragione, nel pensiero di Olivetti la comunità è quel nucleo vivo, pre-utilitario, in cui il rapporto interpersonale ha valore in sé e per sé, che salva e garantisce il rapporto umano in quanto tale, al di là di ogni possibile tornaconto individuale.
La fabbrica, da questo punto di vista, è una comunità. La sua vocazione non può consistere solo nel procurare buoni dividendi per i suoi azionisti. In primo luogo, è certamente chiamata a garantire i mezzi di vita e di sviluppo per la comunità in cui ha avuto origine. Non è, in essenza, un fatto privato. È una risorsa pubblica in senso non statalistico ma comunitario. Con malcelato disprezzo Olivetti considerava che le duecento società multinazionali che oggi hanno in mano il pianeta si basano sul principio della a-territorialità e dal diritto vigente sono ancora considerate meri «domicili privati».
Come in altra sede ho avuto modo di osservare, uno dei punti fondamentali del pensiero olivettiano è il tentativo di umanizzare il potere economico e politico, sciogliendo il dilemma di fondo del nostro tempo, che ci divide fra il bisogno della libertà individuale e le esigenze della giustizia collettiva. I lavoratori non erano per lui dei sudditi sui quali far gravare la tutela del capitalista, per quanto illuminato. Nel pensiero di Olivetti la classe operaia non può venire socialmente, economicamente e politicamente emancipata se non attraverso l’autonoma iniziativa della classe operaia stessa. Parlando agli operai di Ivrea nel Natale del 1955, Olivetti affermava: «Noi crediamo che, sul piano sociale e politico, spetti a voi un compito insostituibile e di fondamentale importanza. Le classi lavoratrici, più di ogni altro ceto sociale, sono le rappresentanti autentiche di un insopprimibile valore: la giustizia; e incarnano questo sentimento con uno slancio talora drammatico e sempre generoso […]. Nell’esperienza tecnica dei primi tempi, quando studiavo i problemi di organizzazione scientifica e di cronometraggio, sapevo che l’uomo e la macchina erano due domini ostili l’uno all’altra che occorreva conciliare. Conoscevo la monotonia terribile e il peso dei gesti ripetuti all’infinito davanti a un trapano o a una pressa e sapevo che era necessario togliere l’uomo da questa degradante schiavitù. Ma il cammino era tremendamente lungo e difficile».
Adriano Olivetti non era dunque solo un buon padrone e non era neppure soltanto un uomo di cultura nel quale si incontravano l’ingegnere e l’umanista. Era un uomo di cultura di tipo nuovo: riteneva indispensabile e moralmente necessario mettere la cultura alla prova, sul banco della pratica quotidiana. E in questo senso era un utopista, ma nel senso classico, fautore di un riformismo, per la tradizione progressistica italiana, del tutto nuovo. Non oscillava fra un massimalismo rivoluzionario a parole, ma in realtà rinunciatario, e un minimalismo dimentico dei grandi ideali di eguaglianza e giustizia sociale. In questo senso Olivetti inventava un riformismo di tipo nuovo, che andava al di là delle due etiche a suo tempo teorizzate da Max Weber, vale a dire l’etica dei principi assoluti e l’etica della responsabilità operativa quotidiana.
Era un uomo di cultura di tipo nuovo: riteneva indispensabile e moralmente necessario mettere la cultura alla prova, sul banco della pratica quotidiana. E in questo senso era un utopista
Nella situazione odierna con l’automazione in un primo tempo, e poi con l’attuale robotizzazione elettronica su vasta scala dei processi produttivi, Olivetti era consapevole che ci troviamo di fronte a sviluppi tecnici che hanno inevitabilmente ricadute psicologiche sulla manodopera di grande rilievo, non ancora determinabili con precisione, ma che Olivetti nettamente intuiva. Di fatto, anche se gran parte dei dirigenti industriali non se ne rende conto, stiamo passando dall’operaio in tuta blu, all’operatore in camice bianco. A questo proposito, insieme con Olivetti si cercava una nuova struttura giuridica alla base della legittimità della grande impresa odierna. Con la transizione dall’operaio all’operatore viene meno infatti il tradizionale rivendicazionismo sindacale.
Fin dal loro Manifesto del Partito Comunista del 1848, Marx ed Engels avevano visto la società radicalmente divisa in due «campi nemici» sulla base del principio della proprietà privata, ossia fra coloro che posseggono i mezzi di produzione e coloro che ne sono posseduti. Questa prospettiva è oggi completamente superata. Ci stiamo muovendo verso una situazione del tutto diversa: la grande azienda può funzionare solo, in realtà, come una comunità collaborativa. Non è paternalismo. È una semplice necessità funzionale. Il principio della proprietà privata è ormai insufficiente.
Con Olivetti si pensava a una nuova base giuridica della grande azienda. Nelle nostre fervide discussioni prendeva corpo l’idea di una quadruplice radice della legittimità proprietaria:
- a) componente tecnologica (il Politecnico di Torino);
- b) comunità territoriale (Ivrea e Canavese);
- c) partecipanti al processo produttivo e distributivo in uno spirito collaborativo e con atteggiamenti non previsti e non prevedibili dai consueti contratti sindacali;
- d) azionisti privati.
In questi termini, nasceva, embrionalmente e forse più come sogno utopistico che previsione scientifica, l’Industria Sociale Autonoma (ISA).
Dopo che Olivetti morì, per infarto o trombosi celebrale, in treno alla volta di Ginevra, la figlia Lalla mi rivelò che gli trovarono in tasca un biglietto con su scritto: «chiamate urgente Ferrarotti». Non era solo per il viaggio che insieme il 7 marzo 1960 avremmo dovuto fare per andare a Hartford, nel Connecticut, per riorganizzare la periclitante Underwood.
Amo pensare che Olivetti avesse in mente la realizzazione dell’Industria Sociale Autonoma da vero imprenditore e non soltanto come amministratore dell’esistente, bensì come un imprenditore demiurgico alla Schumpeter. E forse anche di più: è un autentico sovvertitore dell’esistente, il presago inventore di un capitalismo nuovo non più legato al familismo dinastico, bensì dinamico, aperto, comunitario.
Siamo giunti ad un punto cruciale del pensiero olivettiano: la fabbrica sociale – dalla struttura piramidale alla socializzazione del potere.
Come ricercatore dell’Inter-University International Labor Project, insieme con i colleghi Clark Kerr (Berkeley), John T. Dunlop (Harvard), Charles Myers (MIT) e Frederick H. Harbison (Chicago), mi sono a lungo occupato, nella seconda metà del secolo scorso, di questo nucleo problematico, che per Olivetti costituisce, nella molteplicità dei suoi interessi, il centro della sua meditazione e della sua esperienza di vita. Con riguardo all’impresa così come si è venuta configurando, è necessario tener conto di una profonda evoluzione interna. Dal capitalista-amministratore in proprio, ossia dal detentore dei capitali iniziali, e nel contempo amministratore unico del processo produttivo, si è passati ad una sempre più diversificata e ramificata suddivisione e specializzazione di compiti, mansioni, responsabilità operative. Dal capitalista-proprietario-amministratore al direttore di produzione e al direttore del personale, al direttore delle vendite, ossessionato dal rischio di produrre per il magazzino, e quindi cadere sotto la temibile contraddizione interna del capitalismo, intravista già da Marx come cortocircuito fra sovraproduzione e sottoconsumo. Storicamente, dall’impresa individuale si passa alla società per azioni, non prevista da Marx, anche se si dava già l’esempio del «Patto di colleganza» nella Serenissima Repubblica di Venezia fin dal 1700, per condividere con la proprietà pro-quota delle navi che commerciavano con l’Oriente profitti ed eventuali perdite.
La grande impresa multinazionale odierna determina la vita e il destino di centinaia, spesso migliaia di persone; esercita un potere di fatto sovranazionale; ha quindi una importante funzione politica, ma dal diritto vigente è ancora considerata un semplice «domicilio privato». Inoltre, anche a fini fiscali, è a-territoriale, detentrice di capitali apolidi e vaganti, alla spasmodica ricerca di un profitto, non importa come, non importa dove. Per Olivetti non bisogna mai dimenticare la comunità di origine. Olivetti capovolge inoltre la dottrina e la pratica del «Taylorismo» classico. Quando certi operai ponevano domande e suggerivano soluzioni con riguardo alle linee produttive, si dice che l’ingegnere di Filadelfia, Frederick Winslow Taylor, rispondeva in tono asciutto, che non ammetteva repliche: «Voi dovete lavorare, non pensare. C’è qualcuno che è pagato per questo». Olivetti sapeva, invece, che non si può controllare se non ciò che si conosce e che le condizioni tecniche del lavoro odierno esigono una responsabilità diffusa. In altre parole, nell’azienda di oggi, a tutti i livelli, è necessario socializzare il potere per ottenere un atteggiamento collaborativo da tutti i partecipanti.
Olivetti sapeva che non si può controllare se non ciò che si conosce e che le condizioni tecniche del lavoro odierno esigono una responsabilità diffusa
Musica dell’avvenire. Non per caso Olivetti è rimasto un isolato nella cultura e nella politica italiana. Era in anticipo di almeno cinquant’anni. Mi sussurrava, talvolta, quando avevo un tavolo di lavoro accanto al suo, nella Villa Belliboschi a Ivrea: «Speriamo che le nostre ardite previsioni diventino, fra alcuni decenni, la verità quotidiana. Ci faranno perdonare l‘orgoglio della solitudine».