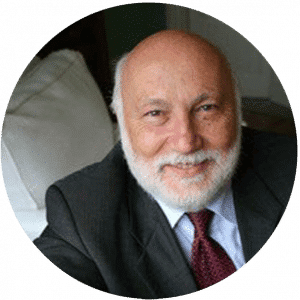
Domenico De Masi, professore emerito di Sociologia del lavoro presso La Sapienza
Professore, mi ha colpito molto una sua affermazione: «Epicentro della nostra società diventa la progettazione del futuro». È possibile progettare il futuro nonostante le emergenze dei nostri giorni?
La complessa fase che stiamo attraversando è segnata dalle incertezze solite, alle quali si sono aggiunte quelle legate alla pandemia e alla guerra. Anche a quest’ultima incognita eravamo particolarmente impreparati, perché in Italia i media usano riservare scarsa attenzione alla geopolitica. Ci riscopriamo quindi in balìa di decisioni che vengono assunte sopra le nostre teste, ma le aziende sono comunque tenute a programmare il lavoro, tenendo conto degli elementi che incidono su questo tipo di programmazione: demografia, sviluppo tecnologico, evoluzione legislativa e rapporto tra tempo di lavoro e tempo di vita.
Le aziende sono tenute a programmare il lavoro, tenendo conto di alcuni elementi: demografia, sviluppo tecnologico, evoluzione legislativa e rapporto tra tempo di lavoro e tempo di vita
Quali novità emergono?
Per quanto riguarda la demografia, a livello mondiale, avremo in qualche decennio, 1 miliardo di persone in più, quindi l’offerta di forza lavoro registrerà un aumento di circa 300 milioni di persone. In Italia, se guardiamo alle prospettive della forza lavoro, potremmo avere circa 1 milione e mezzo di persone in meno ma, se il Paese sarà aperto ai flussi migratori, ci saranno più lavoratori che posti di lavoro. Non mi preoccuperei quindi della disponibilità di lavoratori, ma piuttosto della disponibilità di lavoro, che in Italia manca soprattutto a causa di un gap culturale.
Ci spieghi meglio…
Lo sviluppo tecnologico sta incidendo moltissimo sul lavoro. Prendendo le mosse dalla cosiddetta “legge di Moore”, sappiamo che la potenza dei microprocessori raddoppia ogni 18 mesi. Le tecnologie stanno quindi evolvendo impetuosamente e con l’Intelligenza artificiale sostituiremo non solo il lavoro esecutivo, ma anche molto lavoro intellettuale. Se i campi di lavoro dell’uomo si riducono, l’unica soluzione per far fronte a una crescita della disoccupazione è ridurre progressivamente l’orario di lavoro, favorendo così una redistribuzione dello stesso. Secondo i dati Ocse, un italiano lavora in media 1.723 ore all’anno, mentre un tedesco lavora 1.356 ore e un francese 1.514 ore. Lavoriamo quindi circa 400 ore in più dei tedeschi e, anche per questo, il loro tasso di occupazione supera il 70% mentre noi siamo fermi al 59%. Inoltre, in Germania lavorano di meno, ma producono circa il 20% in più. Infine, su 100 laureati, a 3 anni dalla laurea, in Germania 93 trovano un posto di lavoro, in Italia solo 52. Per alleviare la ferita della disoccupazione la riduzione dell’orario del lavoro è perciò, a mio giudizio, necessaria. Se adottassimo lo stesso orario dei tedeschi potremmo avere 6 milioni di occupati in più, redistribuendo efficacemente il lavoro. Oggi un padre lavora 10 ore al giorno e il figlio è disoccupato; potrebbero benissimo lavorare entrambi 5 ore a testa. Tra gli europei siamo quelli che si ostinano ad avere la settimana lavorativa più lunga, praticamente come quella prevista da Ford nel 1913. Ma in più di 100 anni qualcosa è cambiato, direi.
Certamente, infatti oggi il Paese ha davanti la possibilità di mettere a frutto, in termini di innovazione, quanto è emerso dalle esperienze avviate con lo smart working …
Sì, la pandemia ha impresso un’accelerazione forte in tal senso. Il 1° marzo 2020 in Italia c’erano 570 mila telelavoratori; a metà mese erano diventati 6,5 milioni. In pochi giorni è stato fatto precipitosamente ciò che si sarebbe potuto fare più gradualmente e razionalmente, come avvenuto in Inghilterra, ad esempio. Negli ultimi due anni lo smart working ha contribuito a salvare ambiti come l’economia e la scuola, con impatti positivi anche sull’ambiente in termini di riduzione dell’inquinamento. Si è trattato di un grande esperimento corale. Quindi, le aziende che hanno voluto valorizzare questi due anni per organizzare la transizione da un lavoro industriale a un lavoro post-industriale, hanno avuto tutto il tempo e le possibilità di farlo. E infatti molte imprese hanno oggi tra il 40 e il 50% del personale in smart working. Diversa è invece la situazione della Pa per la quale, nonostante ottimi riscontri avuti in enti pubblici che hanno gestito un numero enorme di pratiche in smart working, è stato deciso di imporre uno stop a questa modalità lavorativa. Come se lo smart working fosse la causa di tutti i mali, invece che una possibilità inedita per risolverli.
Approcci diversi al tema, ma qual è il nodo da sciogliere?
In base ai dati che ho esaminato, la situazione può essere sintetizzata più o meno così: su 100 persone andate in smart working, 10 hanno reso di meno rispetto a quando erano in ufficio, 40 hanno reso allo stesso modo e 50 hanno reso addirittura di più. Non c’è quindi una ragione per giustificare il rifiuto dello smart working. Il problema va forse individuato nella visione di numerosi decisori, chiamati a gestire il personale. C’è chi pensa che il controllo sia un fatto fisico e non organizzativo. Con lo smart working ci si proietta verso un’organizzazione per obiettivi, facilitando così il compito dei capi e dei dipendenti. Del resto, oggi il 75% dei lavoratori lavora con la testa e pensare di poter controllare la testa solo perché il lavoratore sta in ufficio fa quantomeno sorridere. Mentre il corpo si controlla, la mente si motiva. Occorrono capi in grado di motivare.
Oggi il 75% dei lavoratori lavora con la testa e pensare di poter controllare la testa, solo perché il lavoratore sta in ufficio, fa sorridere: il corpo si controlla, la mente si motiva. Occorrono capi in grado di motivare
E in questo senso è essenziale formare manager che abbiano le competenze per guidare le organizzazioni in maniera innovativa. Quanto conta l’aspetto della formazione manageriale?
È essenziale, sicuramente. L’Italia ha avuto una tradizione storica di ottime scuole di formazione volute da grandi aziende ed enti per arricchire il bagaglio di competenze dei dirigenti. Oggi in molti casi non possiamo più contare su queste realtà, anche perché diverse aziende hanno chiuso le loro business school ritenendole un costo e non un investimento. Puntare sulla crescita delle competenze manageriali è invece strategico e bisogna innanzitutto ricominciare dalla “formazione dei formatori”, anche perché le tecniche pedagogiche indirizzate agli adulti hanno specifiche caratteristiche che si sono aggiornate nel corso degli anni. Le imprese devono riprendere a credere davvero nella formazione, destinando ad essa una parte significativa del fatturato.



