L’era dello smart working, del lavoro digitale e dell’economia collaborativa e sospesa. Nello sguardo degli analisti che guardano alle fasi successive dell’emergenza legata al Covid-19, sono tante le immagini e le prospettive che raccontano una trasformazione profonda, a cui il mondo della produzione e del lavoro andrà incontro.
Certamente qualsiasi considerazione sul lavoro che cambia non può prescindere dalla crisi quantitativa a cui il mondo occupazionale si sta avviando. Secondo le stime preliminari dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) si perderanno, a causa del nuovo coronavirus e dei conseguenti lockdown, circa 25 milioni di posti di lavoro, per una riduzione delle ore lavorate nel mondo del 6,7 % nel secondo trimestre del 2020. Ma dietro queste cifre, pur dirompenti nella loro rilevanza, cosa ne sarà del lavoro?
Ne abbiamo parlato con il sociologo Luca Ricolfi, docente di Analisi dei dati all’Università di Torino e presidente e responsabile scientifico della Fondazione David Hume. Nel suo ultimo lavoro La società signorile di massa – edito da La nave di Teseo – il professor Ricolfi ha analizzato la società italiana caratterizzata da una maggioranza di cittadini che non lavorano, da una bassa produttività ma anche da consumi opulenti. Una società, insomma in cui pochi lavorano e molti consumano.
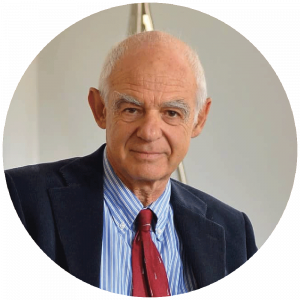
Luca Ricolfi, presidente e responsabile scientifico della Fondazione David Hume e docente di Analisi dei dati all’Università di Torino
Professor Ricolfi, iniziamo dalla società signorile di massa da lei teorizzata. Il lavoro, inteso come fonte di reddito e quindi di potere d’acquisto era già morto prima di questa crisi?
No, non è morto da nessuna parte del mondo, ma in alcuni paesi, quasi tutti europei, è in ritirata. L’Italia fa purtroppo parte del gruppo, con l’aggravante che, avendo un livello di produttività basso e stagnante, la ritirata dal lavoro implica un abbassamento del tenore di vita, nonché una crescente dipendenza dei non lavoratori dalla benevolenza di chi un lavoro ce l’ha, o di chi riesce a estrarre valore da chi lavora.
E cioè?
Dallo Stato, naturalmente, che riesce ad accaparrarsi quasi la metà del prodotto del settore privato, per poi riallocarlo sotto forma di pensioni, sussidi, servizi più o meno efficienti.
E poi arrivò il coronavirus. Lasciando da parte l’aspetto quantitativo e della disoccupazione crescente, come lavoreremo dopo questa crisi? Lei vede una trasformazione, oppure il coronavirus non farà altro che accelerare tendenze già in atto?
Sul piano strutturale la crisi legata al Covid-19 accelererà enormemente tendenze in atto, soprattutto tre: meno Pil, più tasse, più debito pubblico. Ma ne innescherà anche di nuove, prima fra tutte una riduzione delle quote di mercato delle nostre imprese esportatici, che nel giro di pochi mesi perderanno decine di migliaia di clienti, che la crisi del coronavirus dirotterà verso i concorrenti dei paesi più rapidi ad avviare la “fase 2”.
Questo condurrà anche una trasformazione culturale del mondo del lavoro?
Sul piano culturale credo che un po’ di cose cambieranno. Penso che ci sarà – ma in realtà è già in atto – una fortissima spinta a razionalizzare, o a “ridurre la dissonanza”, per dirla con Leon Festinger. I media sono già impegnati con tutte le loro forze a dirci che la crisi in realtà è un’opportunità, a suggerirci di rivedere il nostro modo di vita, riscoprire valori antichi, e via consolando. In un paese cattolico, la fiaba de “La volpe e l’uva” ha un terreno fertilissimo su cui attecchire. Credo che fioriranno i racconti autoconsolatori, come negli anni ’70-’80 fiorì il mito dello “small is beautiful”, un modo per rassicurare una società in cui sparivano le grandi imprese e i connessi centri di ricerca. Sul piano sociale si può immaginare un racconto che enfatizzi le virtù della “comunità” e dei needs for affiliation (bisogni di appartenenza), contrapposti alla logica competitiva dei needs for achievement (bisogni di acquisizione).
Sempre nel suo ultimo lavoro, lei definisce la “disoccupazione volontaria” come “la condizione di chi non lavora non perché non trova alcun lavoro, bensì perché non è disposto ad accettare i lavori che trova”. Crede che i probabili alti tassi di disoccupazione possano attutire il fenomeno?
Sì, la disoccupazione volontaria sarà scoraggiata un po’, ma troppo tardi. Se i giovani tornano a cercar lavoro quando il lavoro non c’è più, l’esito più probabile è un rafforzamento della domanda di sussidi e assistenza.
Se i giovani tornano a cercar lavoro quando il lavoro non c’è più, l’esito sarà un rafforzamento della domanda di sussidi e assistenza
A tal proposito in questi mesi di lockdown gli italiani hanno preso confidenza con assegni, sussidi, cassa integrazione, buoni pasto per i più indigenti. Stiamo facendo le prove generali per una società fondata sul reddito minimo davvero universale?
No, perché non ci sono le risorse per erogare un reddito di base. Però si produrranno le condizioni per dare una sorta di reddito minimo per chi non ha altri redditi, o li ha solo in nero.
Facciamo un passo indietro: la sharing economy è stata per molti la risposta alla crisi economica del 2008: lei ha spesso denunciato che quella modalità di lavoro ha prodotto la schiavitù dei mini job. È possibile che questa nuova crisi stimoli nuove modalità produttive e lavorative più collaborative e solidaristiche?
Senz’altro stimolerà nuove modalità di lavoro. Che poi siano più collaborative e solidaristiche non è detto. Il telelavoro eccita i più ingenui e/o narcisisti, ma ha anche importanti effetti collaterali di colonizzazione della privacy, come non fossimo già abbastanza assediati dal mondo esterno. C’è poi un altro interessante effetto del telelavoro, almeno in determinati ambiti come l’istruzione: l’abbassamento della qualità (della didattica e della valutazione) e la sostituzione dei lavoratori con il software. I docenti che, nella scuola come nell’università, si entusiasmano per le lezioni e le interrogazioni online sono capponi che festeggiano il Natale.
Il telelavoro eccita i più narcisisti, ma abbassa la qualità delle prestazioni e sostituisce il lavoratore con il software
Ci vorranno alcuni anni, ma quelle di questi mesi sono prove generali per sostituire buona parte dell’insegnamento diffuso, face to face, con video-lezioni ed esami computerizzati. Tecnicamente, si può fare licenziando il 70-80% del corpo docente, e se a perdere il posto sarà di meno del 70-80% è solo perché ci saranno resistenze e i sindacati non sono ancora scomparsi del tutto dalla faccia della terra. Quel che mi incuriosisce come sociologo è l’entusiasmo con cui un’intera categoria sta andando incontro allo smantellamento del proprio mondo. Allegria di naufragi, avrebbe detto Giuseppe Ungaretti, cento anni fa.
E questa “tendenza all’autodistruzione” pensa si possa verificare in altri ambiti, oltre all’istruzione?
Non so se fenomeni simili potranno prodursi in altri contesti, ma la mia sensazione è che nella maggior parte degli altri settori saranno subiti, più che assecondati. Del resto stava già accadendo prima del coronavirus, con la progressiva trasformazione di molte professioni (compresa quella medica) in direzione di una maggiore burocratizzazione e digitalizzazione.
Quindi la crescente digitalizzazione secondo lei intacca la qualità del lavoro?
Non so se questo minacci sempre la qualità del lavoro, ma mi pare abbastanza evidente che spesso minaccia la qualità dei servizi erogati, come sa chiunque sia costretto a snervanti odissee telematiche per ottenere un’informazione o una prestazione.



