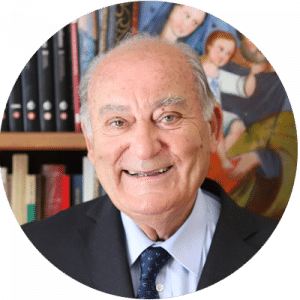
Giuseppe De Rita, presidente del Censis
Dice di essere stato un meridionalista, ma di non esserlo più. Di certo, Giuseppe De Rita è ancora oggi tra i maggiori esperti di Mezzogiorno in Italia e in quest’intervista offre la sua interpretazione del presente e del futuro, prendendo le distanze da quell’atteggiamento «che dagli anni ’50 si continua ad avere verso il Sud».
De Rita, da quanto tempo si occupa di Mezzogiorno e chi considera i suoi maestri?
Ho cominciato a lavorare il primo dicembre del ’55 alla Svimez, l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno e da allora il Sud è rimasto sempre nelle mie corde. I miei maestri sono stati Pasquale Saraceno, che era il capo della Svimez e dei meridionalisti di allora sostanzialmente, mentre colui a cui devo tutto è Giorgio Sebregondi, che è stato l’inventore della sezione sociale della Svimez e in pratica il padre di tutto il lavoro che ho fatto.
Che cosa deve loro?
Da Saraceno ho imparato la programmazione dell’esistenza: era uno che programmava obiettivi di medio-lungo periodo in maniera impeccabile. Da Sebregondi, la parte alternativa, cioè che lo sviluppo non è programmato e deciso dall’alto, ma è crescita dal basso, è divenire. Quindi, quello che ho fatto poi nella mia vita è stato più cantare il divenire, che programmare il possibile.
Che cos’è per lei il Mezzogiorno?
A parte un fatto sentimentale, un fatto storico. Sono nato meridionalista e in parte mi ci sento ancora, anche se ho avuto grandi difficoltà a sentirmi un meridionalista classico. Per me il Mezzogiorno è stato la scoperta del sottosviluppo, della povertà e della diversità. Girare per il Sud negli anni ’50 significava trovare la fame, in alcune zone totale analfabetismo, addirittura incesti familiari. Era una realtà durissima e quindi chi ha vissuto quella realtà, chi l’ha vista, si è messo dentro una voglia di meridionalismo che è molto diversa da quella della programmazione dell’intervento pubblico.
Come è cambiato in tutti questi anni, in particolare rispetto alla povertà?
Il Mezzogiorno oggi è una realtà incomprensibile perché con qualsiasi schema mentale lo si affronti – un’area in industrializzazione, un territorio povero, oppure stabile, o ancora di vita agiata, o invece assistenzialista, ecc. – valgono tutte le risposte e le possibilità. Il Mezzogiorno, per fortuna, sfugge a una sola definizione: è una società molto complessa, in cui alla fine convivono realtà di sviluppo notevole, capacità di movimento in avanti molto forti e una certa indulgenza a sedersi, tipica anche della cultura meridionale, che sussiste ancora. Quindi è un insieme di contraddizioni, però c’è un movimento sotterraneo che dà l’idea che qualcosa stia cambiando e cambierà ancora.
Come è cambiato invece, secondo lei, l’approccio verso il Mezzogiorno negli studiosi?
Chi si occupa di Mezzogiorno sta ancora in una logica di sottosviluppo: c’è sempre l’idea di aggredire il Sud con un forte intervento pubblico. È la difesa di una logica di intervento pubblico e straordinario che non ci lascia dagli anni ’50. Anche quando nel 1993, il ministro Nino Andreatta decise di chiudere la Cassa del Mezzogiorno, quella cultura che aveva portato alla Cassa rimase ancora.
I Patti territoriali, che nascono al Cnel, quando io ero presidente, a metà degli anni ’90, sono stati la grande occasione persa. La logica era quella che si potessero creare dei distretti in modo artificiale e non spontaneo
Lo Stato invece ha cambiato approccio?
Sì, la decisione drastica di Andreatta di eliminare l’intervento straordinario, cioè chiudere la Cassa, ha fatto rifluire gli interventi per il Mezzogiorno nell’ambito dell’intervento ordinario, cioè nei singoli ministeri. Ed è molto più difficile fare politica del Mezzogiorno all’interno di un Ministero, perché lì vince la logica settoriale, non quella meridionale.
C’è stata, secondo lei, un’occasione persa molto importante?
Devo essere un po’ narcisista: l’occasione fondamentale è stata quella dei Patti territoriali, che nascono al Cnel, quando io ero presidente, a metà degli anni ’90. La logica era quella che si potessero creare dei distretti in modo artificiale e non spontaneo. La cosa durò per due-tre anni, ma su indicazione della Corte dei Conti tutto passò dal Cnel al Bilancio, con una delibera Cipe, che ha distrutto l’esperienza.
C’è qualche cambiamento che invece l’ha stupita in positivo?
Mi ha colpito molto la capacità turistica. Io sono figlio di un periodo in cui non c’erano alberghi e le camere in affitto erano orribili: oggi in tutto il Mezzogiorno trovi delle belle strutture. E questo non era tipico della cultura: il meridionale era più contadino, impiegato, insegnante di scuola…
Quindi, il Sud dovrebbe puntare soprattutto sul turismo?
Il turismo mangia l’identità del luogo, basti guardare alcune delle nostre città, come Firenze, dove ora è diventato un problema il turismo invasivo o Venezia, che giustamente cerca di regolamentare gli ingressi. Il turismo è meraviglioso, porta soldi, modernizza le persone, ma è un bene a ridotta capacità di restare nel tempo allo stesso livello. E se perdi l’identità, alla lunga perdi anche i turisti.
Lei ha scritto che “non è l’economia a trainare il sociale, ma viceversa”. Concretamente questo cosa implica per il Mezzogiorno?
Questo viene molto dalla mia esperienza dei Patti territoriali, nel senso che dietro non c’era un grande disegno economico, ma piuttosto la voglia di mettere insieme persone. C’era un processo sociale: è da lì che nasce l’economia, perché il sociale promuove comportamenti collettivi.
Il turismo è meraviglioso, porta soldi, modernizza le persone, ma è un bene a ridotta capacità di restare nel tempo allo stesso livello. E se perdi l’identità, alla lunga perdi anche i turisti
Secondo lei siamo ancora lontani da un vero sviluppo del Sud?
Il Mezzogiorno è in divenire, sono processi in itinere, non possiamo dire che li abbia già completati o che sia già in sviluppo, ma che stia cambiando e che ci sia un cambiamento sì.
Che cosa sarebbe necessario fare secondo lei?
La tentazione sarebbe lasciare andare il Mezzogiorno per come sta andando. Qualsiasi cosa abbiamo pensato di fare in questi anni ha dato dei prodotti, però oggi non c’è nulla di preciso da fare, c’è soltanto da assecondare dei processi che sono appena abbozzati.
Quindi è ottimista?
La mia definizione negli anni ’70 era “De Rita è un ottimista beota”. Non mi sono ancora redento.



